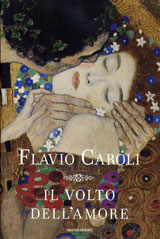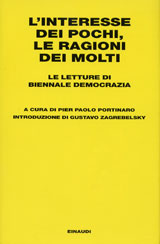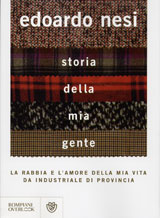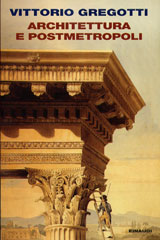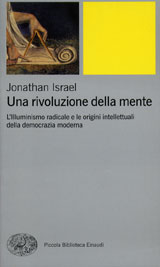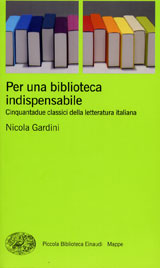SCELTI PER VOI
LUGLIO 2011
(Rubrica a cura di Emanuele ROMALLO)
| SAGGISTICA | ||||
|
Il volto dell’amore di Flavio Caroli Mondadori, 2011 MAG C 6273 Nel percorso compiuto dall'arte per raffigurare il corpo, il volto e l'anima dell'uomo, l'immagine dell'amore occupa un ruolo centrale. Se la letteratura e la filosofia hanno da affrontato il tema con straordinaria profondità, le arti visive hanno dovuto concentrare tutto nell'istante di una sola immagine; per questo sono state a lungo attratte dall'eros. Più arduo si è rivelato il cammino che ha portato alla raffigurazione delle infinite sfumature dell'amore attraverso le fattezze umane, ma la pittura e la scultura si sono dimostrate all'altezza della sfida, dando vita a veri e propri capolavori di introspezione psicologica. Flavio Caroli ci accompagna in un viaggio che prende le mosse dalla sensualità pagana degli affreschi pompeiani e ha il suo punto di svolta con Leonardo da Vinci. Giorgione e Raffaello sono gli artisti che "scolpiscono" per la prima volta la psicologia nei volti dell'amore. L'amore sacro e quello familiare del Cinquecento, l'amore naturale della pittura seicentesca e settecentesca, l'erotismo lieve e carnale di Antonio Canova e quello magico e intenso di Francisco Goya, il bacio romantico e risorgimentale di Francesco Hayez, l'ossessivo tentativo di cogliere l'invisibile attraverso il visibile di Edgard Degas, segnano le tappe di un percorso che vedrà le sue colonne d'Ercole sulla soglia del XX secolo, quando l'inconscio freudiano entrerà con prepotenza nella cultura occidentale. |
|||
|
L’interesse di pochi, le ragioni dei molti (a cura di) P.P. Portinaio Einaudi, 2011 MAG C 6303 "Diciamo cosi, a costo di cadere nell'enfasi: la democrazia vuole potenti gli inermi e inermi i potenti; vuole forti i giusti e giusti i forti. E per questo che i suoi nemici mortali sono le concentrazioni oligarchiche del potere. Il tempo della democrazia non è quello in cui tutto è pacificato. Non è il regno dell'armonia, della giustizia e della concordia. Finché ci sarà politica, ci saranno conflitto, ingiustizia e discordia. La questione non è come eliminarli, ma come affrontarli. La democrazia offre una prospettiva civile e non violenta di confronto tra parti, secondo regole imparziali che escludono l'uso della forza. Il nostro è il tempo in cui gli esseri umani hanno acquisito l'idea della loro originaria uguale libertà e dignità. Le gerarchie sociali, le ingiustizie, le sopraffazioni e le esclusioni dai beni della vita non sono più concepibili come dati dalla natura. Sono arbitri degli uomini. La natura deve essere sopportata, gli arbitri no. Le contraddizioni sono destinate, presto o tardi, a manifestarsi con forza proporzionale alla loro insopportabilità rispetto a quel dato di autocoscienza. La questione è se ciò sarà secondo le regole civilizzate della democrazia, oppure se sarà nello scatenamento della violenza giustiziera. Tertium non datur. Questo è l'impegnativo dilemma che deve essere tenuto presente quando trattiamo della democrazia: impegnativo tanto per la teoria che per la pratica politica". Introduzione di Gustavo Zagrebelsky. |
|||
|
Storia della mia gente Edoardo Nesi Bompiani, 2010 MAG C 6289 "Storia della mia gente" racconta dell'illusione perduta del benessere diffuso in Italia. Di come sia potuto accadere che i successi della nostra vitalissima piccola industria di provincia, pur capitanata da personaggi incolti e ruspanti sempre sbeffeggiati dal miglior cinema e dalla miglior letteratura, appaiano oggi poco più di un ricordo lontano. Oggi che, sullo sfondo di una decadenza economica forse ormai inevitabile, ai posti di comando si agitano mezze figure d'economisti ispirate solo dall'arroganza intellettuale e politici tremebondi di ogni schieramento, poco più che aspiranti stregoni alle prese con l'immane tornado della globalizzazione. Edoardo Nesi torna con un libro avvincente e appassionato, a metà tra il romanzo e il saggio, l'autobiografia e il trattato economico, e ci racconta, dal centro dell'uragano globale, la sua Prato invasa dai cinesi, cosa si prova a diventare parte della prima generazione di italiani che, da secoli, si ritroveranno a essere più poveri dei propri genitori. |
|||
|
Architettura e postmetropoli di Vittorio Gregotti Einaudi, 2011 MAG C 6274 Il trionfo della città nel mondo contemporaneo è diventato un luogo comune: sia nei paesi ricchi che in quelli in via di sviluppo la popolazione urbana cresce costantemente, dando luogo a fenomeni di enorme portata economica, sociale, culturale. Vittorio Gregotti getta uno sguardo sulle città di oggi e sulle possibilità, le sfide e i problemi che esse pongono alla pratica dell'architettura. Se è vero che la globalizzazione della finanza e dei consumi ha trasformato con forza dirompente la nozione stessa di città, l'architettura ha spesso scelto, per comodità o addirittura per convinzione, di ridursi a rispecchiamento dell'ordine globale, all'inseguimento di una bizzarria di superficie e indifferente al suo contesto che tradisce le ragioni profonde del suo essere pratica artistica. Ma è impossibile recuperare una distanza critica nei confronti della post-metropoli trionfante che consenta di disegnarla e progettarla in modo diverso? E non si può sperare che le tendenze accelerate e convulse dei cambiamenti globali potranno depositarsi, dando forma a modalità di architettura urbana altrettanto significative ed equilibrate di quelle del passato? |
|||
|
Ritratti di cittA' di Cesare De Seta Einaudi, 2011 COLL. C 12/921 Il ritratto di città è la forma più alta di celebrazione del potere urbano, sia esso quello di un re, di un papa, di un principe o di un mecenate, e nasce nel Rinascimento con l'invenzione rivoluzionaria della prospettiva. I primi ritratti di città sono databili all'ultimo trentennio del Quattrocento e la loro manifesta intenzione è quella di mettere in scena la bellezza, la prosperità e la grandezza di capitali dell'Occidente come Firenze, Roma e Napoli. L'interesse per queste immagini si propaga a macchia d'olio in tutta l'Europa e non c'è città, sia essa capitale o dominante, che non ambisca a un manifesto ideologico e politico, che in molti casi ha intrinseche qualità d'arte. Questo studio ricostruisce la mappa dei ritratti dal Rinascimento al secolo dei Lumi, sia in senso geografico che tecnico e artistico. Con l'invenzione della stampa il genere conosce un'eccezionale fortuna da cui nascono i primi Atlanti di città dal Miinster ai Merian, a Braun e Hogenberg: sillogi con intenzioni universalistiche che hanno lo scopo di far conoscere città di ogni paese. Sovrani e principi si appassionano a questo soggetto e commissionano affreschi per adornare i loro palazzi. Lentamente il baricentro della produzione iconografica si sposta dall'Italia alla Svizzera, alla Germania e all'Olanda, e poi in Francia, Spagna e Inghilterra. Il Seicento vede il trionfo di questo genere con ritratti incisi e dipinti di città sempre più precisi e ampi. |
|||
|
Una rivoluzione della mente di Jonathan Israel Einaudi, 2011 MAG D 4794 Democrazia, libertà di pensiero e di espressione, tolleranza religiosa, libertà individuale, autodeterminazione politica dei popoli, uguaglianza sessuale e razziale sono concetti che innervano le nostre società moderne. Ma se oggi questi ideali non sembrano più radicali, la loro origine è stata invece molto radicale - molto più di quanto alcuni storici siano ancor oggi disposti a riconoscere. In questo libro Jonathan Israel, uno degli storici più importanti del Secolo dei Lumi, rintraccia le radici fìlosofiche di queste idee nello strato meno conosciuto del pensiero illuminista, in quello radicale, maturato in opposizione all'Illuminismo moderato che dominava l'Europa e l'America nel XVIII secolo (e che in fin dei conti continuava a salvaguardare ampi privilegi per i gruppi al potere: ecclesiastici e nobiliari). Viceversa l'Illuminismo radicale rifiutava di accettare una gerarchia sociale ordinata da Dio e una sanzione divina del potere monarchico e dei privilegi nobiliari, a tutto vantaggio di quelle tendenze livellatrici ed egualitarie delle quali ancor oggi beneficiamo. |
|||
|
Per una biblioteca indispensabile di Nicola Gardini Einaudi, 2011 MAG D 4795 Che cos'è la letteratura italiana? E perché certi libri sono così importanti? Perché leggere ancora il "Decameron", "Il principe" o "Il giardino dei Finzi-Contini"? Attraverso una selezione dei classici della scuola, esattamente 52, tanti quante le settimane dell'anno, "Per una biblioteca indispensabile" vuole rispondere a queste domande, costruendo un campionario di scritture, immagini di mondo e temi culturali che segnano svolte e traguardi decisivi nella storia della civiltà non solo italiana. Con il suo formato anticonvenzionale, che presenta i libri selezionati in ordine alfabetico e non cronologico, una varietà di approcci critici e uno stile limpido quanto appassionato, questo libro evita formule ed etichette accademiche mettendo in evidenza, attraverso la lettura ravvicinata, l'originalità rivoluzionaria dei singoli libri. Di pagina in pagina scaturiscono suggestioni, riflessioni, "incontri" rivelatori; nuove prospettive si aprono all'interpretazione; dettagli apparentemente marginali si dimostrano essenziali e ricchi di senso. Ne risulta un'immagine inedita di letteratura italiana: la letteratura di una nazione che, attraverso l'esercizio delle parole, ha sviluppato il pensiero e l'impegno civile, meditando sull'essenza degli individui e della società, convinta che libri e biblioteche siano un baluardo sicuro contro il dilagare dell'ingiustizia e dell'egoismo e una delle vie principali al raggiungimento della felicità. |
|||
|
Le belle tasse Franco Fichera Einaudi, 2011 MAG C 6302 Le tasse sono in genere viste come un "male", perché consistono in un sacrificio. Dire che sono belle crea un po' di sorpresa. Ma perché dire che sono "belle"? Perché reggono la vita in comune, sono alla base della convivenza civile: tutti siamo chiamati a concorrere alle spese pubbliche, e a sostenere la realizzazione di obiettivi che riguardano tutti. E questo è possibile farlo solo con le tasse. Allora, esse sono un sacrificio per il singolo, è vero, ma per soddisfare un interesse collettivo. Nella vita reale, però, il legame a volte si perde. Resta cosi, impropriamente, solo l'idea del sacrificio. È un equivoco che va spiegato. Ebbene, un giorno, al professor Franco Fichera fu chiesto di spiegare le tasse ai bambini, "lo accettai l'invito e chissà perché la prima cosa che mi venne in mente fu quella di distribuire ai bambini dei cioccolatini". Ne è nato un gioco di ruolo utile ed entusiasmante. |
|||